
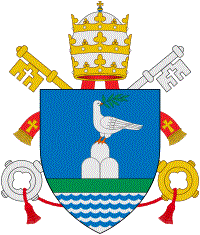
Papa Pio XII, detto Pastor Angelicus (in latino: Pius PP. XII, nato Eugenio Maria Giuseppe Pacelli; Roma, 2 marzo 1876 – Castel Gandolfo, 9 ottobre 1958),
è stato il 260º papa della Chiesa cattolica e 2º sovrano dello Stato della Città del Vaticano dal 2 marzo 1939 al 9 ottobre 1958.
Nel 1990, a conclusione della prima fase di beatificazione, ha ricevuto il titolo di Servo di Dio. Nel 2009, a conclusione della seconda fase,
ha ricevuto il titolo di Venerabile, che ne attesta l'eroicità delle virtù per la Chiesa. La causa di canonizzazione è affidata alla Compagnia di Gesù.
È stato il primo papa ad essere nato nell'Italia unita.
Eugenio Maria Giuseppe Pacelli nacque a Roma il 2 marzo 1876, terzogenito dell'avvocato della Sacra Rota Filippo Pacelli (1837-1916) e di Virginia Graziosi (1844-1920).
I titoli nobiliari della famiglia Pacelli (nobili romani, nobili di Acquapendente e di Sant'Angelo in Vado, concessi alla famiglia nel 1853 e 1858)
erano conseguenza dei tempi della seconda Repubblica Romana (1848-1849). Quando il papa-re Pio IX si rifugiò a Gaeta, Marcantonio Pacelli (1804-1902)
da Onano (Viterbo), nonno paterno di Eugenio, seguì il Papa nella cittadina laziale (allora parte del Regno delle Due Sicilie) e fu premiato con i
titoli di principe e di marchese, sia per la sua fedeltà, sia per aver contrastato efficacemente, dopo la fine della Repubblica, nel ruolo di sostituto
del ministro dell'interno, i liberali che si opponevano al governo papalino. Lo stesso Marcantonio fu, successivamente, tra i fondatori dell'Osservatore Romano (1861).
Dopo le elementari frequentate in una scuola privata cattolica e la frequenza al liceo di Stato "Ennio Quirino Visconti", Eugenio Pacelli entrò
nel Collegio Capranica e poi, dal 1894 al 1899, studiò teologia alla Gregoriana presso cui si addottorò nel 1901, quando già da due anni era stato
ordinato sacerdote nel 1899, precisamente il 2 aprile (domenica di Pasqua) dall'imposizione delle mani del vescovo Francesco di Paola Cassetta.
Del 1902 è la laurea in giurisprudenza in utroque iure (vale a dire, sia in diritto civile, sia in quello canonico), anche se non ebbe mai modo
di praticare l'avvocatura, strada che seguì suo fratello Francesco, giurista per la Santa Sede e uno dei principali negoziatori dei futuri Patti
Lateranensi del 1929. Eugenio sentì sin da piccolo la "vocazione": pare che nei momenti liberi amasse far finta di celebrare la messa. Determinante
per la sua formazione fu l'influenza che ebbe, a partire dall'età di 8 anni, il reverendo Giuseppe Lais, scienziato astronomo, discendente da una
storica famiglia romana di origine sassone, per molti anni precettore e mentore del futuro papa Pio XII, in seguito insignito da papa Benedetto XV
della medaglia d'oro pontificia.
Dietro raccomandazione del cardinale Vincenzo Vannutelli, che più tardi sarebbe diventato decano del Sacro Collegio, Pacelli iniziò una rapida
carriera nella Curia romana come segretario del cardinale Pietro Gasparri (futuro segretario di Stato), all'epoca sottosegretario della Congregazione
per gli Affari Ecclesiastici straordinari. Nel 1904, dopo la specializzazione accademica in relazioni fra Stato e Chiesa, fu promosso e divenne
monsignore-ciambellano di papa Pio X. Pacelli vide con favore l'introduzione del giuramento antimodernista da parte di Pio X, preoccupato per le
influenze libertarie che stavano contagiando il clero italiano, e si applicò con zelo alla stesura di un nuovo codice di diritto canonico e,
a partire dal 1911, alla carica di consultore presso il Sant'Uffizio e nello stesso anno divenne sottosegretario della congregazione per gli
affari ecclesiastici straordinari. Nello stesso anno rappresentò la Santa Sede all'incoronazione di Giorgio V.
In questa veste fu artefice del concordato stipulato tra il Regno di Serbia e la Santa Sede il 24 giugno 1914, pochissimi giorni prima dell'inizio
della prima guerra mondiale, tuttavia non ci sono prove storiche fondate che facciano supporre che tale accordo fosse una delle cause delle tensioni
con il confinante Impero austro-ungarico, che culminarono poi nello scoppio del conflitto bellico.
Il 13 maggio 1917 (lo stesso giorno in cui è avvenuta la prima apparizione della Madonna a Fatima), Benedetto XV lo ordinò vescovo elevandolo
in pari tempo alla dignità arcivescovile con il titolo di arcivescovo di Sardi in partibus e lo nominò nunzio apostolico in Baviera. Dopo la
consacrazione, il neovescovo disse che mentre passeggiava nei Giardini Vaticani avrebbe assistito stupefatto al "miracolo del sole". Questa
fu una delle cause della forte devozione di papa Pacelli nei confronti della Madonna di Fatima.[1] Dal 1925 Pacelli fu anche nunzio apostolico
in Prussia. In tale doppia veste egli concluse i concordati con i due Länder: con la Baviera nel 1924, con la Prussia nel 1929.
Sempre nel 1929, l'11 febbraio, il capo del governo Benito Mussolini e il cardinal Gasparri firmarono i Patti Lateranensi, frutto della mediazione
di Domenico Barone e di Francesco Pacelli. Contemporaneamente, dal 1920, fu il primo nunzio per l'intera Germania con sede nella nuova nunziatura
di Berlino. Durante questi dodici anni Pacelli si avvicinò molto al mondo tedesco e conobbe bene la realtà politica della Repubblica di Weimar.
Il 19 aprile 1919, durante la cosiddetta rivoluzione promossa dalla Lega spartachista, di ispirazione comunista, la nunziatura di Monaco di Baviera
fu accerchiata da un gruppo di rivoluzionari, che intendevano farvi irruzione. Il leader del gruppo, Siedl, estrasse una pistola e la puntò al
petto di Pacelli, il quale si era personalmente posto a difesa dell'entrata della nunziatura. Sebbene scosso, il nunzio non intendeva cedere,
affiancato da una coraggiosa suora tedesca, Pascalina Lehnert, che si era interposta tra i rivoluzionari e il nunzio. Siedl non se la sentì di
andare avanti e ordinò agli spartachisti di ritirarsi[2]. Pacelli scriverà al riguardo:
« Sono dei veri e propri russi bolscevichi. »
Eugenio Pacelli fu creato cardinale da Pio XI il 16 dicembre 1929; il 7 febbraio 1930 divenne segretario di Stato. Al fine di regolare le
relazioni tra la Santa Sede e le autorità locali negoziò diversi concordati, tra i quali quelli con il Baden (Germania) nel 1932, l'Austria
nel 1933 e la Jugoslavia nel 1935. Il più discusso tuttavia fu quello firmato a Roma il 20 luglio 1933 con la Germania del cancelliere Adolf Hitler, il Reichskonkordat.
Foto della firma del Reichskonkordat. Da sinistra a destra: Monsignor Ludwig Kaas, il Vice-cancelliere tedesco Franz von Papen, il Sottosegretario
ecclesiastico Giuseppe Pizzardo, il Cardinal Segretario di Stato Eugenio Pacelli, Alfredo Ottaviani e il Segretario del Ministero degli Interni tedesco Rudolf Buttmann.
Questo concordato, che pure garantiva i diritti dei cattolici tedeschi, dava un ulteriore riconoscimento internazionale al regime nazista a pochi mesi dall'ascesa di Hitler
al potere (30 gennaio 1933), che segnò la fine di ogni vita democratica in Germania e la proibizione di tutti i partiti politici, compreso quello
cattolico del centro (Zentrumspartei). Pacelli aveva ricercato con costanza un concordato sin dal periodo della sua nunziatura, negli anni venti.
Heinrich Brüning, leader della Deutsche Zentrumspartei, partito cattolico di centro, dichiarò nelle sue memorie che Pacelli, in occasione di un
incontro del 1931 (quando Brüning era cancelliere), avrebbe insistentemente premuto per la dissoluzione dell'accordo di coalizione con il partito
socialdemocratico, ponendola quasi come una condizione per la stipula del concordato, ma il cancelliere avrebbe respinto la sollecitazione
considerando che il prelato fosse in grave errore di valutazione sulla situazione politica tedesca e, in particolare, sul peso del nascente partito nazista.
Pio XI morì il 10 febbraio 1939. In qualità di camerlengo, toccò proprio a Pacelli dirigere il conclave che ne seguì. Il 2 marzo 1939, giorno
del suo 63º compleanno, dopo solo tre scrutini e un giorno di votazioni, la scelta ricadde sullo stesso Pacelli, che si impose il nome di Pio XII,
a simboleggiare la continuità dell'operato con il precedente capo della Chiesa. Fatto insolito per un conclave, fu eletto colui che, alla vigilia,
aveva le migliori possibilità di diventare papa. In effetti Pacelli rappresentava un'ottima scelta politica in quanto era il più esperto in diplomazia
tra i cardinali del Collegio. Pacelli fu il primo segretario di Stato dal 1667 (Clemente IX) e il secondo camerlengo (dopo Leone XIII) a venir eletto papa.
L'elezione e l'incoronazione di Pacelli ebbero un'accoglienza mista in Germania. Da parte della maggioranza della stampa tedesca, quella più vicina
al partito nazista, giunsero commenti alquanto ostili: il Berliner Morgenpost scrisse che «l'elezione di Pacelli non è accolta favorevolmente in
Germania poiché egli è sempre stato ostile al nazionalsocialismo»; la Frankfurter Zeitung scrisse che «molti dei suoi discorsi hanno dimostrato
che non comprende del tutto le ragioni politiche e ideologiche che hanno iniziato la loro marcia vittoriosa in Germania». Il giornale delle
SS lo "Schwarze Korps" scrisse: "Il Nunzio e Cardinale Pacelli ci ha dimostrato scarsa comprensione,ed è per questa ragione che noi gli accordiamo
poca fiducia. Pacelli ora Pio XII non seguirà sicuramente una strada diversa". Goebbels riporta nel suo Diario che Hitler aveva pensato all'abrogazione
del concordato se Pacelli fosse stato eletto papa. L'"Ufficio centrale per la sicurezza del Reich" (RSHA) descrisse l'elezione di Pacelli al soglio
pontificio con accenti molto negativi: il nuovo papa veniva considerato un amico delle democrazie, che esultavano per la sua elezione (nel rapporto
dell'RSHA veniva riferito il commento favorevole sul nuovo pontefice de «L'Humanité», l'organo ufficiale del Partito Comunista Francese) e si ricordava
come Pacelli, da Segretario di Stato, si fosse fatto notare per i suoi attacchi al nazionalsocialismo.
Eletto in un periodo di grandi tensioni internazionali, con il regime nazista che iniziava ad occupare molti territori europei, il Papa tentò invano
di scongiurare il rischio di una nuova guerra mondiale con diverse iniziative, fra cui la più famosa è il discorso alla radio del 24 agosto 1939,
in cui pronunciò la frase simbolo del suo pontificato: "Nulla è perduto con la pace; tutto può essere perduto con la guerra". Tuttavia tali iniziative
furono inutili. Il 1º settembre, la Germania invase la Polonia e il 3 Francia e Regno Unito risposero all'attacco: è la seconda guerra mondiale.
Papa Pacelli tentò con altri appelli di far cessare le ostilità e organizzò aiuti alle popolazioni colpite e creò l'ufficio informazioni sui
prigionieri e sui dispersi. Cercò, inoltre, di distogliere il fascismo dall'idea di far entrare in guerra l'Italia, ma nonostante ciò il 10
giugno 1940 anche l'Italia entrò in guerra.
Il 19 luglio 1943, dopo il violento bombardamento di San Lorenzo a Roma, si recò nei quartieri colpiti, uscita eccezionale del Pontefice dal
Vaticano (allora il Papa usciva dal suo Stato in casi estremamente rari); l'episodio è ricordato da Francesco De Gregori nel brano musicale
San Lorenzo. Durante la visita papa Pacelli spalancò le braccia alla folla recitando il salmo De profundis. Dopo l'armistizio dell'8 settembre
e la fuga dei Savoia dalla capitale, Pio XII dovette fronteggiare da solo l'occupazione nazista della città. Negli ultimi giorni di maggio del
1944, i tedeschi si preparavano alla fuga e avevano minato i ponti sul Tevere per impedire alle forze angloamericane di procedere nell'avanzata verso nord.
Pacelli ammonì: "Chiunque osi levare la mano contro Roma, si macchierà di matricidio". Tra gli altri interventi, documenti recentemente venuti
alla luce testimoniano la sua difesa delle donne della Ciociaria e del basso Lazio contro le violenze dei soldati di passaggio. Il 4 giugno 1944,
dopo la Liberazione, ricevette in Vaticano i soldati alleati. La domenica successiva i romani si recarono in massa a Piazza San Pietro a salutare e
a festeggiare il Papa, che, di fatto, era stata l'unica autorità, non solo religiosa, ma anche morale e politica, ad essere rimasta nella capitale
nei mesi bui dell'occupazione nazista. Per questo Pio XII fu anche soprannominato "Defensor civitatis".
Negli anni successivi, Pio XII, anche per il suo carattere schivo e introverso, ridusse all'osso l'organizzazione della Curia Romana (dal 1944
non nominò nessun nuovo Segretario di Stato). Tuttavia fu un papa particolarmente amato dalla gente: istituì l'Angelus domenicale dalla finestra
di Piazza San Pietro e fu il primo papa le cui immagini vennero trasmesse in televisione (sul cui uso emise anche un'enciclica, la Miranda Prorsus).
Grazie alla conoscenza di numerose lingue, fu uno dei primi a rivolgersi in lingua straniera ai pellegrini che venivano a Roma. Nel 1950 affermò,
nella Humani Generis, la compatibilità tra fede cattolica ed evoluzionismo, nondimeno considerando l'evoluzione una teoria scientifica e non una
realtà già dimostrata, e la necessità di doverose ulteriori chiarificazioni concettuali.
Nel 1951 in un discorso alle ostetriche offrì delle considerazioni contro i tentativi di procurare la sterilità nell'atto coniugale, ma ammise
la liceità dei rapporti sessuali scegliendo per essi il periodo di sterilità naturale della donna.
Inoltre, in molti discorsi ai giovani sposi, rilanciò il ruolo della famiglia e del matrimonio e indicò la Sacra Famiglia come modello di
santità per le famiglie. Venendo incontro alle richieste del mondo moderno autorizzò diversi provvedimenti, preludio delle riforme del
Concilio Vaticano II: permise la celebrazione della Messa nelle ore serali, apportò modifiche alla lettura dei salmi nel breviario dei
sacerdoti, riorganizzò l'ufficio del digiuno eucaristico riducendolo a tre ore per i cibi solidi, a un'ora per le bevande ed eliminandolo
del tutto per l'acqua e i medicinali.
Pio XII morì nel Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo alle 3:52 del 9 ottobre 1958 a seguito di un'ischemia circolatoria e di collasso polmonare, all'età di 82 anni.
Conclusa l'ostensione e celebrate le esequie, la salma di Pio XII venne deposta in un sarcofago lapideo nelle Grotte Vaticane, vicino alla tomba di Pietro (il cui sito
era stato individuato proprio sotto il suo pontificato).